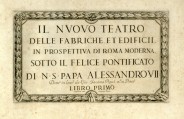
Piazza San Pietro col terzo braccio del colonnato progettato da Gian Lorenzo Bernini
Dopo la morte di Innocenzo X, che gli aveva a lungo preferito Francesco Borromini, e l’elezione al soglio pontificio di Alessandro VII, a Bernini fu affidata nel 1656 la sistemazione di piazza San Pietro. Non si trattava di un’impresa facile poiché bisognava rendere l’accesso alla basilica spettacolare, solenne ed elegante, riducendo al minimo gli interventi sugli edifici preesistenti, garantendo la giusta visibilità alla cupola di Michelangelo, ai Palazzi apostolici e alla Loggia delle benedizioni, e mitigando l’eccessiva larghezza della facciata di Maderno. Nello stesso tempo era necessario trovare una soluzione funzionale ad accogliere grandi quantità di fedeli, cui andavano garantite la sicurezza prima, durante e dopo le funzioni. Bernini fece un capolavoro, realizzando una piazza unica al mondo, divenuta il simbolo del barocco italiano. Dalla facciata della chiesa, due bracci porticati rettilinei si spingono in avanti in maniera divergente per poi aprirsi in due emicicli che, con una selva di colonne, abbracciano tutta la vasta piazza in cui si raccolgono i fedeli, come le braccia della Chiesa accolgono l’intera umanità. Un “terzo braccio”, rappresentato nella incisione di Giovanni Battista Falda e mai realizzato per la morte di Alessandro VII, avrebbe dovuto continuare la curva dei due emicicli sul lato della “spina di borgo”, saldando la nuova piazza con il paesaggio urbano preesistente.
Giovanni Battista Falda, Piazza e portici della Basilica Vaticana fatti da n.s. papa Alesandro settimo, in: Id., Il nuovo teatro delle fabriche et edificii in prospettiva di Roma moderna..., vol. I, Roma 1665