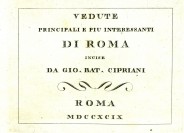
Il lago di piazza Navona
Piazza Navona fu dal XV secolo una delle aree più vitali del centro urbano. Vi fu trasferito il mercato cittadino e divenne luogo di scambio e di intrattenimento, per la presenza di molte botteghe di negozianti e artigiani. Nel Seicento, grazie alle magnifiche creazioni di Borromini e Bernini, e alla committenza di papa Innocenzo X Pamphilj, si trasformò in una delle più belle piazze barocche di Roma. Divenne luogo privilegiato per la predicazione, come per la festa, per le pratiche devote come per le occasioni di svago. La veduta di Cipriani mostra la Piazza durante una "festa dell'acqua": a partire da metà Seicento, nei fine settimana d'agosto, la piazza veniva trasformata in un "lago", grazie alla chiusura delle condotte che raccoglievano l'acqua di esubero delle fontane. La finalità era lo svago, oltre che il procurare sollievo dall'aria torrida dell'agosto romano. Come testimonia la veduta, il "lago" era attraversato da persone a piedi, gondole, carrozze, che a volte davano luogo a veri e propri giochi e gare sfarzose.
Giovanni Battista Cipriani, Piazza Navona, in: Id., Vedute principali e più interessanti di Roma, Roma 1799