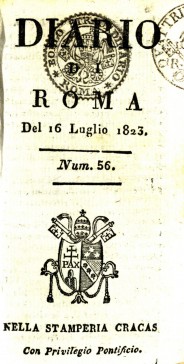
Notizia dell'incendio della basilica di San Paolo dal giornale romano "Diario di Roma"
Il terribile incendio sprigionatosi nella notte del 15 luglio 1823 dal tetto della Basilica di San Paolo ebbe grande risonanza su gazzette e giornali dell'epoca. Il primo a riportare la notizia, poi ripresa anche da testate estere, fu il Diario di Roma, detto comunemente Chracas, dal nome della famiglia degli stampatori. Il giornale dei Chracas comparve nel 1716 con lo scopo specifico di dare notizia degli avvenimenti della guerra d'Ungheria (Diario d'Ungheria). Cambiò nel tempo nome (Diario ordinario, Diario di Roma), formato (tascabile, di pochi fogli, di numerose pagine), e orientamento, passando di mano in mano tra i diversi membri della famiglia. Fino a Ottocento inoltrato pubblicò, in forma breve o per esteso, notizie sui principali avvenimenti politici, religiosi e militari italiani ed esteri, rappresentando una fonte di notizie di cronaca di inestimabile ricchezza.
Diario di Roma, n. 56, 16 luglio 1823